Una disputa sui social intorno al ‘catcalling’ sta rivelando come il dibattito linguistico non possa quasi mai fare a meno del settarismo concettuale
Il trend topic del momento è sicuramente il catcalling. Non soltanto perché è stata Aurora Ramazzotti ad avviare recentemente una serie di rimandi a catena sul tema, ma anche perché imperversa proprio da qualche ora un post di Vera Gheno su Facebook attraverso il quale la studiosa ha inteso approfondire e chiarire in senso linguistico e storico-linguistico le prerogative del termine. Il fatto è che, per così dire, siamo partiti dall’analisi linguistica, ma in un attimo siamo finiti a discettare senza freni e senza troppi riguardi relativamente al concetto del termine stesso.
‘Catcalling’, come spiega efficacemente Vera Gheno, si può tradurre letteralmente e con perfetta identificazione con l’originale mediante la locuzione: molestia di strada. In inglese il vocabolo indica quel fenomeno dopo essere stato coniato in realtà nell’ambito teatrale per descrivere una manifestazione rumorosa di dissenso. Per intendersi, il vocabolo in questione con il gatto non ha niente a che vedere. Se state richiamando l’attenzione del vostro gatto che si attarda in giardino quando invece dovrebbe rientrare prontamente in casa, non abbiate timore: non è ‘catcalling’..!
Con il conforto di una interessante panoramica (linkata nel post) sulla terminologia utilizzata negli anni, apprendiamo che tra gli anni Cinquanta e Settanta il termine più in voga per descrivere il fenomeno era ‘pappagallismo‘ ma, come notano autorevoli linguiste che hanno rivolto la loro attenzione al termine, la pratica descritta da quella voce con il passare del tempo ha finito per essere derubricata a fenomeno, per così dire, goliardico. Il ‘catcalling’, invece, non è una zingarata o una semplice ragazzata: è una molestia nel più giuridicamente cristallino dei significati. L’aspetto disarmante è che il post, che aveva la finalità di chiarire il significato del termine ma anche, in maniera legittima, quella di ribadire segnatamente la stigmatizzazione del fenomeno, ha raccolto alcune obiezioni (di provenienza maschile, per quel che ho potuto constatare) in cui, mediante uno stizzito senso di fastidio, si manifestava l’insofferenza per la condanna che impedirebbe, a detta degli autori delle stesse repliche, di formulare liberamente dei pensieri a proposito dell’eventuale visibile avvenenza di una persona. Cito letteralmente la replica che la dottoressa Gheno ha proposto all’obiezione che ho riferito.
C’è una bella differenza tra pensare che unə ha un bel culo – o delle belle spalle, dei bei capelli, delle gambe tornite – e sclacsonarlə o gridarglielo in faccia.
L’obiezione la dice lunga sull’incapacità di talune persone (non stiamo ovviamente parlando in maniera esclusiva di uomini: l’utilizzo dello schwa da parte della scrivente lo specifica in maniera efficace) di scindere il pensiero dall’azione. E in questo risiede proprio il problema. Nel caso specifico (ancora di più che in altri casi) l’immaginazione può andare anche al potere, come si auspicava in una locuzione di altri tempi, ma l’importante è che resti immaginazione. Se io, dopo un diverbio, immagino di fare a pezzi il mio vicino di pianerottolo e programmo idealmente con il solo pensiero di riporre il risultato della mia azione di smembramento ordinatamente in sacchetti di plastica nel freezer, non commetto un reato. Se metto in pratica quel proposito, inanello invece certamente tutta una serie di capi di imputazione. Tutto sommato è un giochino facile facile che dovrebbe riuscire anche a quegli uomini ancorati irrimediabilmente ai miti intramontabili di manifestazione della virilità. D’accordo, è vero: a volte tra due fenomeni molto diversi il discrimine è labile. Avviene anche nel calcio, per esempio. È un po’ la differenza che c’è tra una partita correttamente ‘maschia’ e una piena di falli. Perché ridete..?


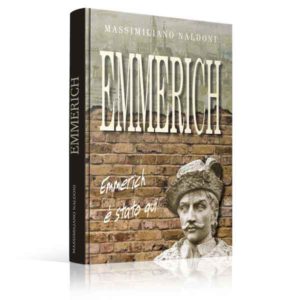
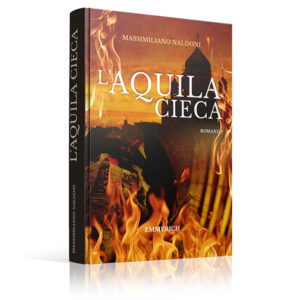


Comments are closed.